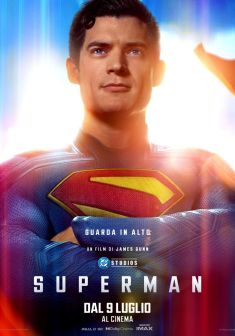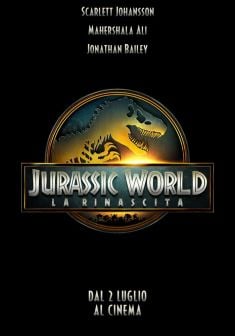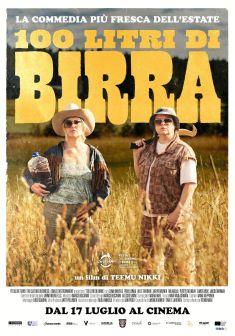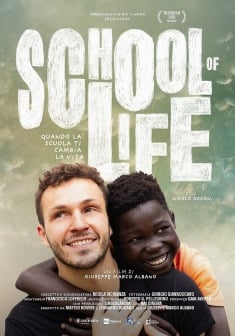Il Re Leone, la nostra recensione del remake Disney
L'apice del Rinascimento degli anni Novanta rivive in CGI fotorealistica.
Erede al trono di papà Mufasa (voce di Luca Ward), il piccolo leoncino Simba si ritiene responsabile della morte di quest'ultimo, ma è un complotto ordito dallo zio Scar (Massimo Popolizio). Fuggito lontano in preda ai sensi di colpa, Simba diventa adulto (con la voce di Marco Mengoni) abbracciando una filosofia spensierata, inculcata in lui dal suricata Timon (Edoardo Leo) e dal facocero Pumbaa (Stefano Fresi). Almeno finché l'amata leonessa Nala (Elisa) non lo troverà e lo spronerà a riprendersi il regno...
Sì, il plot del remake del Re Leone, firmato dal Jon Favreau che già diresse quello de Il libro della giungla (2016), è esattamente uguale all'originale del Re Leone (1994). E non è solo questione di trama. Forse per un timore reverenziale verso il film che 25 anni fa rappresentò l'apice del Rinascimento animato Disney dei Novanta, anche la stessa sceneggiatura segue al 95% la successione delle scene che furono portate sullo schermo all'epoca da Roger Allers e Robert Minkoff. Il nuovo copione ad opera del Jeff Nathanson di Prova a prendermi (!) si limita in sostanza a trovare modi più o meno convincenti di allungare ogni sequenza per portare la durata del film dai vecchi 88 minuti agli attuali 118. Il ritmo ne risulta dilatato nei dialoghi, con qualche digressione trascurabile, ma riproponendo le stesse canzoni di Elton John & Tim Rice, con un solo nuovo brano, pleonastico come la maggior parte delle aggiunte spalmate su questa mezz'ora "integrativa".
A parere di chi scrive, Favreau aveva realizzato col suo Libro della Giungla il più sensato dei remake disneyani dell'ultimo periodo, giustificando la rivisitazione con un'inclusione dei temi di Kipling solo sfiorati nel cartoon. Cerchiamo invano qui un'analoga freschezza: in assenza di temi e spunti nuovi, alla fine ci concentriamo su ciò che stride tra la concezione del primo cartoon e la sua rivisitazione. A parte il citato problema della dilatazione dei tempi, l'allestimento dei numeri musicali perde tutta la forza fantastica e visionaria che aveva nell'animazione a mano libera, esplosione di colori e astrattismo: la decisione di rimettere tutto in scena con una CGI "verista" rende più strani e posticci i sipari cantati e i personaggi più caricaturali come Timon e Pumbaa. Accadeva anche nel Libro della Giungla, ma appunto lì si era distratti dall'apprezzamento delle differenze narrative.
E' un grosso peccato, perché tecnicamente Il re leone "2.0" è uno spettacolo non solo di altissimo livello, ma anche più disneyano di quanto si possa pensare. In vita Walt Disney fece dell'osservazione della natura il soggetto del suo cinema, sia attraverso un'animazione mimetica del reale, ossessiva nella sua plausibilità (si veda Bambi), sia con la produzione di veri e propri documentari: Deserto che vive (1953) vinse un Oscar. La computer grafica dell'inglese Moving Picture Company ricompie il miracolo di rendere accettabile un animale fotorealistico che parla come un essere umano, quindi i due universi del documentario e della fiction si sposano con un successo che nel primo goffo esperimento di Dinosauri (2000) si poteva solo sognare.
Ciò che Disney invece non avrebbe fatto sarebbe stato applicare un tale spiegamento di mezzi e una tale ricerca tecnica a un sentiero già battuto, per giunta "riaprendo" uno dei classici animati che – giustamente – riteneva eterni. Il paradosso del nuovo Re Leone è che, lungaggini a parte, ci si appassiona comunque alla storia, ci si diverte e ci si commuove, semplicemente perché ci si è appassionati, ci si è divertiti e ci si è commossi col film originale. L'esperienza funziona perché è una spudorata copia quasi-carbone di un altro lungometraggio che già funzionava. Il rischio è distrarsi e pensare che il "ti piace vincere facile" sia nel DNA del nucleo creativo della Disney, quello tenuto a battesimo proprio da Walt.
- Giornalista specializzato in audiovisivi
- Autore di "La stirpe di Topolino"